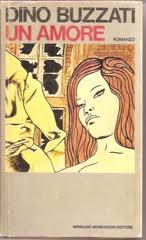Compiti per tutti: non leggete mai Dino Buzzati prima di andare a dormire.
Se proprio perché siete degli idioti vi dovesse capitare, la mattina dopo scappate dal letto del misfatto, lavatevi il viso con l’acqua gelida di gennaio e quello che vi ha fatto più male, fate come me, ricopiatelo. A penna, a macchina, battetelo sulla tastiera, ripetetelo a memoria sbagliandolo. Insomma, fate qualcosa, qualsiasi cosa, ma esorcizzatelo.
Vogliate scusarmi, io non ho copiato tutto tutto, voi potete fare di meglio. Giustificate queste espunzioni con la pigrizia nella copiatura, basterà a capirne il senso. I dettagli narrativi e didascalici – che pure mi ricordano qualcuno se ci penso, e almeno per i minuti che restano a queste parole non vorrei pensarci – sono insiti in ciascuno di noi, in forme apparentemente diverse.
Sarebbe poi un così grande sgarbo agli animi inquieti e innamorati, a me, a voi, dire tutto, come se tutto si potesse dire, che ho preferito evitare.
Allora ho eliminato le scogliere, la campagna della periferia milanese, il nome di lei (Laide, ndr), qualche patema d’animo di troppo, le descrizioni accessorie e fondamentali, ho espunto tutto il resto del libro, Un amore (Arnoldo Mondadori editore, 1963), considerato dagli eruditi un insolito nella produzione di Buzzati.
Forse, in effetti, questa vicenda nabokoviana non è un romanzo ma una scheggia di luce, è un raudo inesploso che nelle pagine deflagra al rallentatore, un segreto confessato una volta da sbronzi e poi seppellito. Per sempre.
In fondo, qui, per i non eruditi che ancora si ostinano a imparare l’amore, per i puri, c’è già tutto quello che basta: Antonio Dorigo (di Dorigo ne è pieno il mondo) che spinge il pedale sull’acceleratore verso il baratro felice di un non amore e la corsa verso Laide, ché anche lei abita le donne di ogni dove, incolpevoli stupide ninfette indifferenti quando il cuore è il malato organo degli altri.
Ho già detto troppo. È che qui c’è l’allusione più bella a quel ciclico e imprevedibile scambio di ruoli che è l’avvicendarsi dei rapporti umani. Troppo, sì. Troppo uguali sempre, noi, uguali l’inizio, la fine, le donne, gli uomini, le stesse storie per tutti, il dolore, e nel dolore la gioia, l’amore, la morte, l’amore, per sempre.
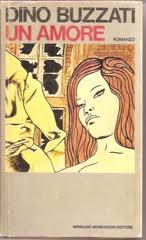
Un amore, Dino Buzzati, pagg. 108/114
“Svegliarsi presto, per Antonio, è morte civile.
[…] Partì alle sei e mezzo. Trovò le strade vuote. Peccato che il cielo fosse grigio.
La sveglia alle sei, di per sé dolorosissima, fu una specie di meraviglia all’idea di lei che lo aspettava.
Ogni volta che il piede pressava sul pedale dell’acceleratore era uno spazio in meno che lo separava da lei.
[…] La campagna deserta, prati fumiganti di nebbia e in fondo lunghi schieramenti di pioppi altissimi a quinte successive che si perdevano nelle lontananze. Via via che lui correva, da una parte e dall’altra gli alberi ruotavano concentrandosi in folla verso l’estremità del rettilineo e poi sgranandosi di fianco, mentre altri, più lontani gli correvano avanti a rinserrarsi verso l’orizzonte; come se due immense piattaforme girassero in senso opposto una a destra, una a sinistra.
[…] Poi gli parve che nel loro moto, corrispondente in senso inverso allo spostamento della macchina, i filari dei pioppi intendessero dirgli una cosa. Sì, la fuga degli alberi – intreccio fluido e cangiante di prospettive in una duplice rotazione della campagna a perdita d’occhio – aveva assunto una speciale intensità di espressione come quando uno sta per parlare.
Lui correva, volava anzi in direzione dell’amore e pure gli alberi che scivolando al limite delle praterie, erano portati via da qualcosa più forte di loro. Ciascuno aveva una sua fisionomia, una forma speciale, una sagoma diversa. Ed erano tanti, migliaia e migliaia. Eppure una comune forza li trascinava nel gorgo. Tutti i pioppi della smisurata campagna fuggivano esattamente come lui ruotando in due vastissime ali ricurve.
Era uno spettacolo, nel solitario mattino, con la strada vuota dinanzi e i prati vuoti, le campagne vuote, non si vedeva un’anima, sembrava che, tranne lui, tutti si fossero dimenticati che esistesse quel pezzo di mondo. E lei era laggiù in fondo dietro l’ultimissimo sipario di alberi anzi molto più in là, probabilmente stava dormendo con la testa sprofondata nel cuscino, fra lista e lista delle tapparelle la luce del giorno nuovo penetrava nella stanza illuminando la massa dei suoi capelli neri, immota. Era sola?
Allora, egli all’improvviso capì il senso di quel naturale incantesimo. Di colpo egli capì ciò che tutta la natura gli diceva, capì il significato del mondo visibile allorché esso ci fa restare stupefatti. […] Tutta la vita era vissuto senza sospettarne la causa. Solo adesso, finalmente, si rendeva conto del segreto.
Un segreto molto semplice: l’amore. Tutto ciò che ci affascina nel mondo inanimato, i boschi, le pianure, i fiumi, le montagne, i mari, le valli, le steppe, di più, di più, le città, i palazzi, le pietre, di più, il cielo, i tramonti, le tempeste, di più, la neve, di più, la notte, le stelle, il vento, tutte queste cose, di per sé vuote e indifferenti, si caricano di significato umano perché, senza che noi lo sospettiamo, contengono un presentimento d’amore.
Quanto era stato stupido a non essersene mai accorto finora. Che interesse avrebbe una scogliera, una foresta, un rudere, se non vi fosse implicata una attesa? E attesa di che se non di lei, della creatura che ci potrebbe fare felici?
Dovunque c’era nascosto il pensiero inconfessato di lei, anche se non sapevamo neppure chi fosse.
[…] Se quando era ragazzo uno glielo avesse detto, e lui avesse potuto capire, ciononostante avrebbe sempre detto di no, che non era vero, per una forma di pudore. Così anche gli altri diranno di no, che è un’idiozia, che è retorica, romanticismo fuori tempo. Eppure, interrogati, non sapranno indicare altrimenti perché li commuove la burrasca marina o l’arco diroccato dei Cesari o la dondolante lanterna nel vicolo dei bassifondi. Mai confesseranno che in quelle scene c’è anche per loro il richiamo a un sogno d’amore, nonostante il disgusto che una simile espressione possa dare.
[…] Eppure se nei viaggi non ci fosse quel barlume romanzesco e inverosimile, non si muoverebbero da casa. Il vagabondare di frontiera in frontiera, di albergo in albergo, diventerebbe un supplizio.
E il fatto universale della poesia? Come mai tanti paesaggi, selve, giardini, spiagge, fiumi, alberi, crepuscoli nei versi della donna amata? Perché nella natura, i poeti, più ancora degli altri riconoscono il riferimento fatale. Le torri antiche, le nuvole, le cateratte, le enigmatiche tombe, il singhiozzo della risacca sullo scoglio, il piegarsi dei rami alla tempesta, la solitudine dei greti nel pomeriggio, tutto è un’indicazione precisa a lei, la donna nostra, che ci incenerirà.
Ogni cosa del mondo congiurando con le altre cose del mondo in complotto sapientissimo per promuovere la perpetuazione della specie.
Era un’intuizione così bella e geniale che in altre circostanze egli ne avrebbe avuto soddisfazione. Ma, proprio per la sua esattezza, oggi a lui procurava solamente dolore. L’espressione degli alberi fuggenti corrispondeva infatti alla condizione del suo amore; il quale era stolto e disperato. Egli correva in direzione di lei benché sapesse che laggiù lo aspettavano soltanto nuovi affanni, umiliazioni e lacrime. Ma lui correva a perdifiato ugualmente, il piede premuto con tutta la forza sul pedale, per la paura di perdere un minuto.
I pioppi della pianura, spostandosi processionalmente, a schiena curva, sembrava gli dicessero: fermati, uomo, fa’ dietro front, non pensare più a lei e seguici, non correre alla tua rovina. Noi ti condurremo al remoto paradiso degli alberi dove esiste soltanto benessere, canto di uccelli e pace d’animo. Non ostinarti.
Era così persuasivo il loro discorso che a un tratto egli fu preso da un turbamento interiore, si spostò sulla destra e si fermò.
Ma nello stesso istante si è fermato anche tutto il paesaggio intorno a perdita d’occhio e a lui dinanzi, in fondo alla deserta pista d’asfalto, il crocchio degli alberi rimane compatto e immobile né si scioglie più sgranandosi da una parte all’altra, i pioppi non sfuggono più, non gli dicono più fermati, non osano più dirgli niente perché capiscono che non c’è nulla da fare, gli alberi gli dicono sì è vero, laggiù in fondo, al sud, dove la strada finisce, c’è lei che aspetta per farti dannare, ma non importa, tanto!
Tanto, il sole è già alto, e noi non ti possiamo salvare.”
Ecco, è troppo.

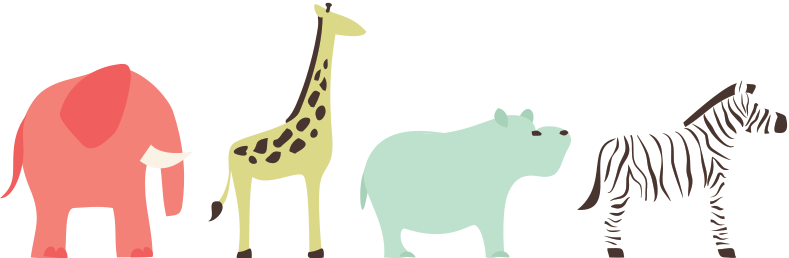
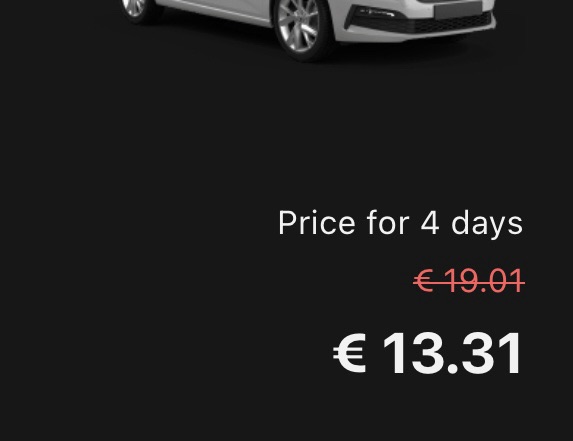


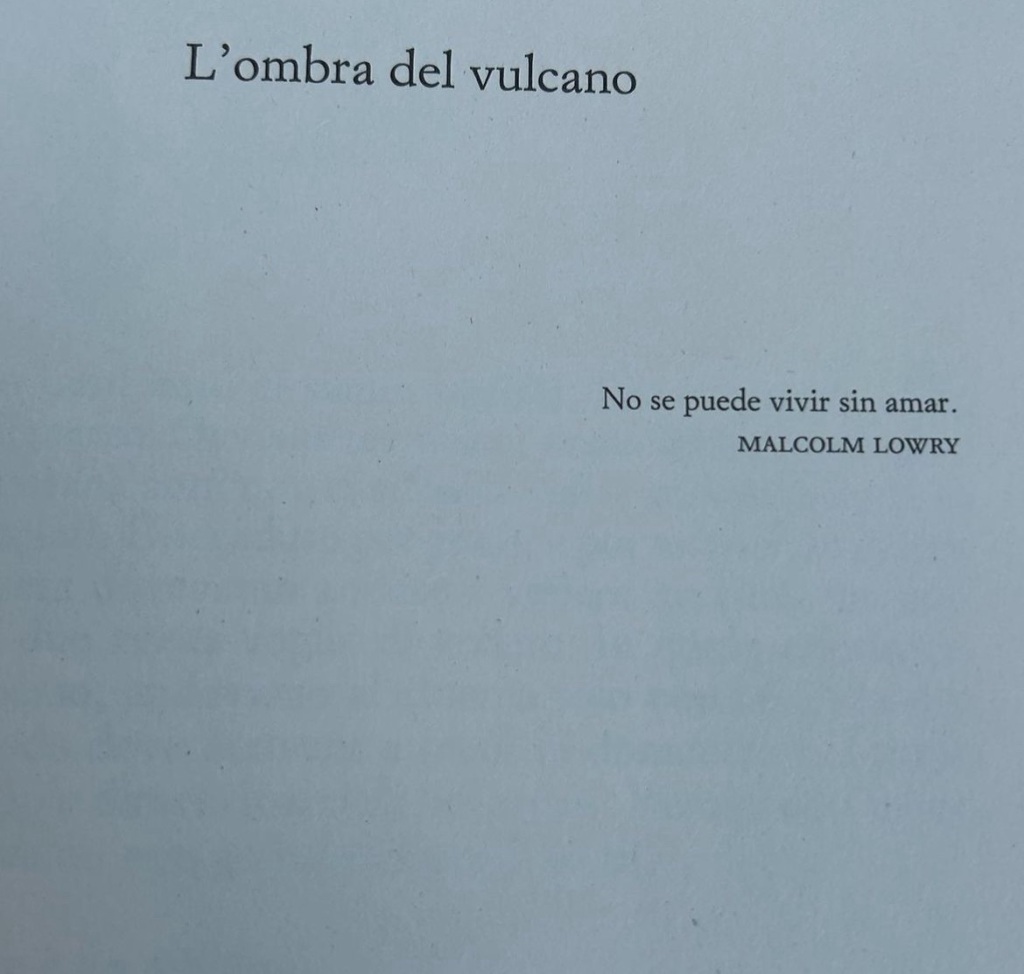
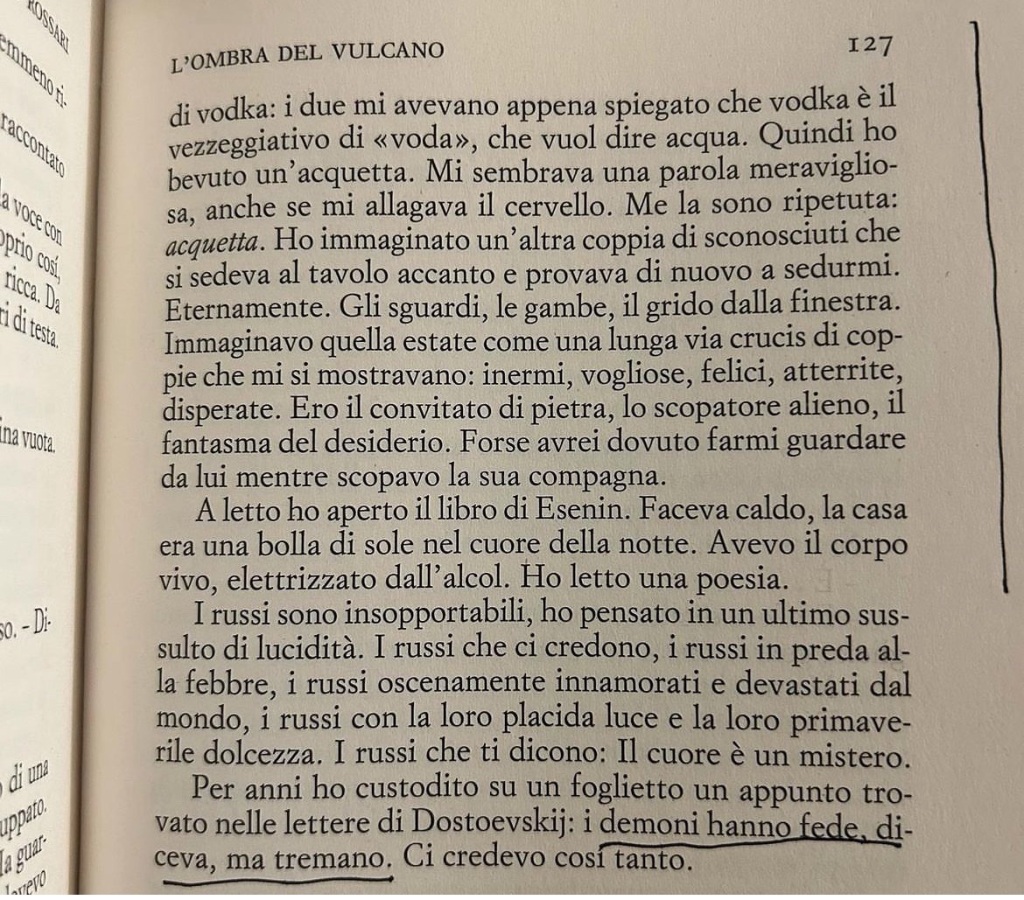





 Certe volte mi sono anche azzardata a pensare che sia stata tutta tua la colpa, il germe di quel disfacimento morale iniziato in un momento indefinito della mia adolescenza e protrattosi a colpa perpetua. Io volevo te, tu non potevi volere me, semplice come nei libri: disfatta, tragedia, condanna a morte, epilogo. Nessuno avrebbe immaginato che sarebbe potuta andare molto peggio. Che ci saremmo sentite, a tratti, due buone amiche a relativa distanza impegnate ogni due settimane al massimo tre a custodire un pezzo di vita tutto sommato felice, perché andata. Io avrei collezionato donne con la stessa urgenza disperata di chi ha una scadenza di morte e dilapida ogni risparmio fino al giorno in cui per magia continuerà a vivere, tu non mi conoscevi più. Che poi mi avresti amata, nessuno poteva saperlo, e io mi sarei rifiutata di farlo, malata cronica di passato, come una bambina cresciuta incontra la madre da cui fu rifiutata e a sua volta la rifiuta, la maltratta, compie l’incesto e la umilia. Si può fingere di non sapere che l’amore è un silenzioso ritorno all’utero, alle origini della vita, quando tutto è solo inizio eterno senza tempo. Ma io era l’unica cosa che sapevo. Ho rifiutato me e mandato indietro te, lì sulla collina di una scuola dalla quale ancora ridi senza amore, senza futuro, sei ancora perfetta e bellissima. Non ti ho capita, ma non ho amato nessun altro. Retrocedi di dieci anni e stai ferma per tutta la vita, pescava la carta dei vigliacchi. Era già tutto scritto, per tutti la fine scrive gli inizi già prima che comincino. Non è mai possibile una nuova vita, un nuovo inizio, la probabilità di rimanere illesi al tempo e al suo determinismo spietato equivale a zero, non a due. Eppure.
Certe volte mi sono anche azzardata a pensare che sia stata tutta tua la colpa, il germe di quel disfacimento morale iniziato in un momento indefinito della mia adolescenza e protrattosi a colpa perpetua. Io volevo te, tu non potevi volere me, semplice come nei libri: disfatta, tragedia, condanna a morte, epilogo. Nessuno avrebbe immaginato che sarebbe potuta andare molto peggio. Che ci saremmo sentite, a tratti, due buone amiche a relativa distanza impegnate ogni due settimane al massimo tre a custodire un pezzo di vita tutto sommato felice, perché andata. Io avrei collezionato donne con la stessa urgenza disperata di chi ha una scadenza di morte e dilapida ogni risparmio fino al giorno in cui per magia continuerà a vivere, tu non mi conoscevi più. Che poi mi avresti amata, nessuno poteva saperlo, e io mi sarei rifiutata di farlo, malata cronica di passato, come una bambina cresciuta incontra la madre da cui fu rifiutata e a sua volta la rifiuta, la maltratta, compie l’incesto e la umilia. Si può fingere di non sapere che l’amore è un silenzioso ritorno all’utero, alle origini della vita, quando tutto è solo inizio eterno senza tempo. Ma io era l’unica cosa che sapevo. Ho rifiutato me e mandato indietro te, lì sulla collina di una scuola dalla quale ancora ridi senza amore, senza futuro, sei ancora perfetta e bellissima. Non ti ho capita, ma non ho amato nessun altro. Retrocedi di dieci anni e stai ferma per tutta la vita, pescava la carta dei vigliacchi. Era già tutto scritto, per tutti la fine scrive gli inizi già prima che comincino. Non è mai possibile una nuova vita, un nuovo inizio, la probabilità di rimanere illesi al tempo e al suo determinismo spietato equivale a zero, non a due. Eppure.